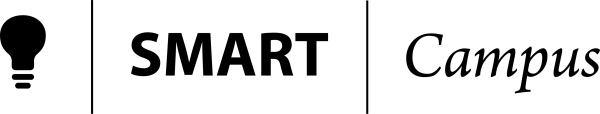Conosciamo il mondo attraverso le parole. Queste vengono stampate, pubblicate, trascritte, trasmesse, urlate, censite, estrapolate e buttate in prima pagina. Rappresentano il modo presso cui conosciamo non solo la realtà che ci appartiene, quella nostra, ma soprattutto sono il mezzo che utilizziamo per arrivare dove il nostro sguardo non arriva, il campo visuale esterno. Campo in cui, spesso e volentieri, agiamo non solo tramite le parole ad esso riferite ma rispetto a quel processo che attuiamo nel momento in cui una situazione, più o meno complessa e di cui non facciamo esperienza diretta, entra all’interno della nostra percezione. Le recepiamo e le convertiamo in immagine, le filtriamo e finiamo per attribuire ad esse sentimenti, sensazioni e meccanismi che vanno ad alterare la natura stessa di un’informazione.
La lingua, in verità, è facile al fraintendimento. Lippmann sosteneva che il linguaggio «non è affatto un veicolo perfetto di significati». Lo stesso incastro di parole utilizzate da chi contribuisce alla costruzione di un messaggio non attecchisce nello stesso modo e non assume lo stesso significato a chi ne presta ascolto. Se riuscissimo a dare un unico nome, se riuscissimo ad attribuire un unico valore non cadremmo all’interno di un circolo interpretativo diversificato, allo stesso tempo non saremmo quello che siamo, degli esseri umani.
Esseri che mettono in atto fin troppe componenti cognitive, percettive, emotive, che attecchiscono alla sfera dei valori e a quelle che concernono il nostro vissuto e le nostre esperienze. Anche se ci dovessimo trovare di fronte ad un accadimento riusciremmo a non essere pienamente attendibili e a non riportare per filo e per segno la notizia così com’è. La credibilità del testimone oculare diviene fine a sé stessa. Alla realtà che gli si pone davanti aggiunge in maniera inconscia elementi che non gli appartengono, finendo poi per rappresentare non la realtà stessa dei fatti di una informazione ma la sua trasfigurazione.
«Il ruolo dell’osservatore è sempre selettivo e di solito creativo. I fatti che vediamo dipendono dal punto di vista in cui ci mettiamo, e dalle abitudini contratte ai nostri occhi».
Nella genesi della formazione di un’opinione dobbiamo tener conto della complessità del nostro essere e dell’ambiente che ci circonda. Ambiente che attualmente vive immerso in un bagno di rumore continuo e assordante.
Nel 1922 Walter Lippmann parla di menti confuse dal brusio della società moderna, della impossibilità a potersi concentrare e riflettere senza il peso del pensiero stesso reso frustrato dalla routine, parla della difficoltà a rinascere nel silenzio e nell’abbandonarsi alla noia mortale che dalle pressanti vicissitudini viene castrata e calpestata. Parla dell’assenza del silenzio e quindi dell’assenza della riflessione a causa di un incessante e frenetico rumore di fondo. Nel 1922 l’autore parla di narcosi quando ancora il digitale non aveva visto lontanamente luce, eppure, afferma:
«Comprendiamo allora perché le nostre menti confuse afferrino così poco con precisione, perché vengono catturate e sballottate, in una specie di tarantella, da titoli di stampa e parole d’ordine, perché così spesso non siano in grado di vedere le differenze tra le cose o di cogliere l’identità tra cose apparentemente diverse».
All’interno del caos e del disordine di queste cose, l’informazione viene diffusa e generalizzata ad un tipo di sensibilità quella più comune, raramente viene diversificata e resa speciale. La comunicazione, di conseguenza, ne risulta appiattita e il peso stesso delle parole viene reso uguale ai più, convergendo così il flusso dell’opinione pubblica in picchi di fraintendimento assoluto. Lo stesso individuo, infatti, può reagire in maniera diversa ad uno stesso stimolo o allo stesso stimolo in un momento diverso.
Se si cerca su Google il termine “politically correct” in meno di 0,35 secondi si ottengono 2.150.000 risultati. Non entreremo all’interno della questione che può risultare particolarmente divisiva. Quello che mi pare più opportuno far notare è che in un’epoca in cui non si ha tempo ed è tutto celere scegliere determinate parole piuttosto che altre risulta determinante per cercare di comunicare lo stesso messaggio senza alterare nessuna delle parti. Le parole hanno un peso e questo peso deve essere bilanciato alle diverse sensibilità umane.
Vi è un principio di omologazione del sentire – sentimenti, sensazioni e percezioni – nel momento in cui si organizza una comunicazione poiché si pensa di colpire tutti in egual modo e di poter recepire uguali reazioni all’accaduto, al fatto, alla parola. I significati che si recepiscono tramite le parole attecchiscono a diversi microcosmi che non possono essere sempre prevenuti ma a cui si deve necessariamente pensare. La percezione relativa, i diversi gradi d’istruzione, le possibilità di vita ed economiche differenti, il contesto in cui si è e in cui si cresce, le persone di cui ci circondiamo, i diversi tipi di esperienza influiscono forse più di un periodo grammaticale corretto quando traduciamo un pensiero lontano. Una frase nasconde più significati di quanto si possa pensare.
Il tempo necessario e lo spazio di riflessione, ancor di più, sono due coordinate fondamentali per far sì che possa nascere un’azione di pensiero, una pubblica opinione. Tempo e spazio che non trovano posto o la giusta dimensione all’interno delle piazze virtuali dei social. Allora che tipo di ragionamento può nascere all’interno di un contesto in cui la riflessione non trova né quello e né l’altro? Solo idee fragili?
La lunghezza delle captions o dei post dei vari social, dettate da regole interne o imposte dalla stessa comunità, non permettono di poter dare sfogo e sfoggio ad una idea o ad un pensiero. L’arte del ragionamento qui non trova posto perché non c’è spazio o perché anche se questo esiste non trova l’attenzione da parte degli utenti perché appunto “too long, didn’t read”.
Secondo uno studio di Jeff Bullas un post su Facebook da 1 a 80 caratteri registra un engagement maggiore del 66% rispetto ai post che ne superano gli ottanta. Su Twitter, nonostante vi sia stato un leggero cambiamento nel 2017, i caratteri da poter utilizzare sono solo 280. Le regole non cambiano nemmeno quando si inizia a parlare di multimedialità. Nonostante il cervello umano riesca a processare sessanta mila volte più velocemente i video piuttosto che i testi, i più visti su Youtube vanno dai 30 ai 50 secondi. Questo non stupisce anzi consolida la nascita ed il successo delle stories nei diversi mondi zuckerberghiani – Facebook, Instagram e Whatsapp, nonostante l’idea sia stata storicamente rubata a Snapchat – non sconvolge neppure l’affermarsi di Tik Tok, social media nato appositamente per la creazione di video di massimo sessanta secondi. Non desta nemmeno nessun scalpore che, poi, conseguentemente, Zuckerberg abbia immesso all’interno del suo meta-regno i reels, video con un massimo di trenta secondi. Questo spiega il fatto che più si è brevi e celeri più si è d’impatto in un posto virtuale in cui si riesce a mantenere la concentrazione non più di otto secondi a contenuto.
Limitazioni e difficoltà d’attenzione oltre un tempo specifico sono causa e fonte di tematiche poco argomentate sui social. Social che dovrebbero essere il posto di espressione massima e di ascolto condiviso dai più.
“Don’t tell me words don’t matter” potrebbe essere lo slogan esplicativo del motivo per cui nell’epoca in cui si viaggia più veloce della luce bisogna trovare tempo e spazio per trovare le giuste parole per motivare, argomentare e discutere le proprie idee. In un luogo in cui l’essenzialità sembra esserne il principio cardine potremmo cercare di trovare una spiegazione a questo fenomeno affidandoci alle conoscenze scientifiche delle neuroscienze. La lettura di un testo cartaceo mette in circolo e funzione complessi circuiti neuronali quali quelli dell’immaginazione, del linguaggio e della memoria. La lettura sul web, invece, mette in gioco e attiva i circuiti decisionali. Secondo Carr «la rete spezzetta il contenuto e interrompe la concentrazione» e Internet diventa un «ecosistema di tecnologie dell’interruzione».
Kerckhove, invece, parla di intelligenza connettiva ovvero di quella intelligenza che un individuo sostiene attraverso la connessione con le altre menti. Per quest’ultimo i social media sono acceleratori dei processi connettivi, per Carr, invece, strumenti di frammentazione del pensiero. Due modi di vedere la stessa realtà sociale virtuale che anche se in opposizione tendono a completare, a parer mio, la visione di cosa è un social network adesso ovvero l’unione di più menti, di più esseri pensanti aventi pensieri frammentati, a volte anche veloci e superficiali, ma non sempre. Al nostro interrogativo se l’arte del ragionamento e il tempo della riflessione trova spazio all’interno di un luogo in cui l’essenzialità sembra essere dominante risponde Norcini Pala, il quale afferma che:
«A differenza dei media tradizionali, teoricamente capaci di creare impalcature cognitive alla strutturazione del pensiero, in una dinamica costruttiva e per certi versi anche generativa, i social tendono a puntellare le idee dell’utente, spesso approssimative e instabili, rafforzandole con la consistenza di una presupposta verità e certezza condivisa. Ma anche ben puntellate, le idee fragili restano tali».
Riferimenti bibliografici:
-
Walter Lippmann, L’opinione Pubblica, Roma, Donzelli Editore, 1999.
-
Liraz Margalit, Did Video Kill Text Content Marketing?, in <www.entrepreneur.com>.
-
Nicholas Carr, Internet ci rende stupidi? Come la Rete sta cambiando il nostro cervello, Milano, Raffaello Cortina Editore, 2011.
-
Gabriele Caramellino, Un caffè con… Derrick de Kerckhove, in <nova.ilsole24ore.com>, 27 maggio 2010.
-
Lanfranco Norcini Pala, Social… mente. Come si formano le idee e l’opinione pubblica tre rete e social, Cinisello Balsamo, Edizioni San Paolo, 2020.